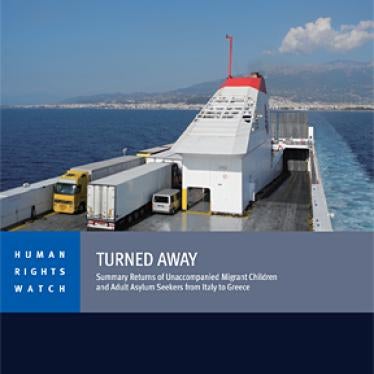Nel luglio del 2006, andai in Libia da Karthum. Andammo prima a Sukh, e da lì, a Kufra. Ci vollero 21 giorni per attraversare il deserto del Sahara. C'erano 46 persone nel nostro gruppo alla fine del viaggio.
I trafficanti si drogavano. Non avevano portato pezzi di ricambio per il mezzo. Rimanemmo bloccati nel deserto senza cibo né acqua. L'accordo originario era di pagare 250 dollari per andare da Karthum a Kufra. Ma nel mezzo del deserto, i Sudanesi ci consegnarono ai Libici, i quali ci dissero che dovevamo pagare altri 300 dollari altrimenti ci avrebbero abbandonato nel Sahara prima di raggiungere la Libia. Circa il 74 percento di noi fu in grado di pagare ma pagammo anche per gli altri così che nessuno rimanesse escluso.
Da Kufra, dovemmo pagare altri 300 dollari per andare a Bengasi. Usarono la forza e ci minacciarono con coltelli. Ci picchiarono, ma senza gravi conseguenze. Secondo gli accordi ci dovevano portare direttamente, ma ci tennero per due giorni in una casa fuori Kufra, dove hanno preteso altri soldi e ci hanno costretto a pagare.
Credo che i trafficanti fossero legati al cento per cento alla polizia e all'esercito. Vidi gli ufficiali in uniforme con le stelle sulle spalline parlare ai trasportatori. E gli autisti ci dicevano "nessun problema" quando vedevamo la polizia o i militari. I trafficanti ci dicevano anche che saremmo finiti in prigione se non avessimo pagato.
Fummo in grado di proteggere tutti quanti nel gruppo. Non lasciavamo che separassero le ragazze, e nessuno finì in prigione.
Da Kufra andammo a Bengasi in un posto appena fuori dalla città. Ci rimanemmo solo una notte, e il giorno dopo partimmo per Tripoli. L'anno e mezzo successivo lo passai a Tripoli.
Non ci fu verso di trovare lavoro a Tripoli. La Libia non è un Paese civile. Vivevo con degli amici. Avevamo sempre paura di camminare per strada. La gente cercava sempre di prenderci i soldi, e dovevamo scappare. Fumavano hashish e ti rapinavano. Non ebbi problemi con la polizia a Tripoli. Scappavo sempre quando li vedevo.
Qui [a Roma] porto il crocifisso. Lì non lo portavo. C'era una Chiesa italiana, cattolica. A volte mi ci nascondevo. La chiesa era in pieno centro. C'erano sempre degli stranieri, per cui non c'era rischio che ti facessero del male di fronte a loro. La chiesa era un posto sicuro.
Non rimasi lì con le mani in mano. Ho provato a scappare dalla Libia per quattro volte.
La prima volta che cercai di scappare era l'ottobre del 2006. Eravamo un gruppo di 108 persone. I trafficanti ci dissero che avevano una buona barca, ma era un piccolo peschereccio e dopo averlo visto rifiutammo di imbarcarci. Appena lo vidi mi resi conto che sarei morto se ci fossi salito. Imposero a due persone di salire e il resto del gruppo cominciò a battersi. Arrivarono molti soldati e ci catturarono.
Avevano un accordo con la marina per prendere i nostri soldi. Ci misero direttamente nell'ufficio portuale della marina militare. Quelli che pretendevano soldi da noi portavano uniformi della marina. Erano in buona forma fisica. Erano chiaramente della marina, li so riconoscere. Non erano della guardia costiera, ma della marina. Un alto ufficiale ci parlò.
Ciò che mi sorprende è che la persona che ci disse che ci avrebbe portati in Italia è la stessa che ci arrestò. Quelli che ci arrestarono erano in borghese. Quelli che dicevano che ci avrebbero portati erano in uniforme. Ma furono tutti loro insieme ad arrestarci.
Cercammo di disperderci. Due del nostro gruppo scapparono via. Ma gli altri furono presi e imprigionati. Io fui uno dei detenuti.
La marina [libica] ci catturò e ci portò in una stazione di polizia chiamata Zanzur. Da quella stazione di polizia portarono sei di noi che erano cristiani in tribunale. Solo noi sei, non gli altri 108. Non potemmo capire cosa fu detto in tribunale. Da lì ci portarono in un posto chiamato Jawazat. Era una prigione per immigrati. Era dalle parti di un posto chiamato mercato Cremia. È un campo di deportazione dove vengono portati gli egiziani. Mi tennero lì per due mesi. Era il decimo mese dell'anno, il Ramadan, ed io ero uno dei sei cristiani. Dicevano che ci avrebbero trattato diversamente, ma in realtà non ci davano alcun cibo durante il giorno, solo di sera, quindi digiunavamo contro la nostra volontà.
Eravamo nella stessa stanza con altri 160. Tutti in una stanza. Era come un garage per auto con solo dei buchetti in alto come finestre. Dovevamo urinare in bottiglie di plastica da buttare via la sera. Ci permettevano di andare in bagno solo una volta al giorno. In molti avevano problemi alla pelle. Non c'era sapone. Ci davano acqua da bere in un barattolo. In molti avevamo problemi di stomaco. Dovevamo supplicare le guardie di portare al bagno chi stava male.
Le guardie erano crudeli. Si drogavano. Li vedevamo fumare hashish tutti i giorni. E scherzavano, "Dove sono i cristiani che non stanno digiunando?" Si vedeva come ci discriminassero e ci dicevano che non gli piacevano i cristiani.
Un giorno, stavamo cantando. Arrivarono le guardie e ci dissero, "Chi sta facendo chiasso?" Gli altri dissero, "Sono i cristiani". Tirarono fuori noi sei e ci picchiarono. Ci percossero i piedi con una mazza di legno. Picchiarono sulle piante dei piedi tra i cinque e i dieci minuti. Due guardie sistemarono un pezzo di legno sotto le nostre gambe, e poi legarono le gambe al legno. Cademmo all'indietro, e poi colpirono sui piedi. Ce lo fecero a tutti e sei. Ci colpirono solo sui piedi. Sanno che dopo le percosse non sei in grado di camminare, ma ci fecero correre introno al cortile dopo averci colpito i piedi. Questo accadde a mezzanotte. Il capo del campo non era lì quando questo accadde, ma tutte le guardie sapevano che stava succedendo.
Ora sto bene. Non ci sono stati danni permanenti, ma la prigione è stata molta rigida per me. Condiziona la tua identità, chi sei. Ti vedono come inferiore e ti senti inferiore a loro, fisicamente e spiritualmente.
Dopo due mesi, ci misero con un altro gruppo di eritrei, 150 persone in tutto. Ci misero su un grosso camion. Era così pieno che nessuno aveva lo spazio di sedersi. Rimanemmo tutti in piedi. La sola aria che entrava proveniva da dei buchi sul tetto del camion; altrimenti era completamente chiuso. Il camion ci portò da Tripoli a Kufra. Partimmo alle 6 del mattino, e viaggiammo tutto il giorno e la notte successiva. Il camion rimase chiuso per tutto il viaggio. C'erano delle fessure nel pavimento, e orinavamo da lì. Mi facevano male gli occhi dalla puzza.
C'erano anche alcune ragazze sul camion. Non era pesante solo per le donne; era molto difficile anche per gli uomini. Li pregammo di farci prendere aria. Il camion sostava così che gli autisti potessero mangiare, ma a noi non aprivano la porta. Temevano che scappassimo. Il peggio fu quando arrivammo a Kufra. Quando ci muovevamo almeno l'aria circolava. A Kufra, ci fermammo per due ore con un caldo a 45 gradi e si respirava a fatica. Il camion era fatto di metallo. Ci tennero lì due ore per punizione perché avevamo urlato durante il viaggio. Dio è grande! Siamo sopravvissuti tutti.
Quando ci fecero scendere dal camion, eravamo alla prigione di Kufra. Ci passammo una settimana. Ci davano da mangiare soltanto una volta al giorno. Solo riso. Il Ramadan era finito. Avevo già patito due mesi di fame in prigione. Adesso eravamo 800 prigionieri ammucchiati in diverse stanze. Dormivamo su pezzi di cartone. Non c'erano materassi. Era sporco. Le guardie non ci parlavano. Aprivano e chiudevano le porte, e basta.
Kufra è il posto di confine per la deportazione. Da lì ti lasciano, perché non c'è alcun altro posto dove andare. Ci sono sempre tre nazionalità lì - sudanesi, eritrei, ed etiopi. A Kufra, ti ributtano nel tuo Paese. Non ti accompagnano al confine vero e proprio, ti lasciano solo andar via.
Ma i trafficanti sono in combutta con il comandante della prigione. Quando ci lasciano andare, siamo pronti per il mercato. Gli autisti ci aspettano fuori dalla prigione di Kufra e contrattano per portarci a Tripoli. Ci dicono di aver pagato per tirarci fuori di prigione. Poi ci portano fuori città in un luogo in piena campagna.
Dovevamo dargli la tangente di 40 dinar per averci liberato oppure 400 dollari per arrivare a Tripoli. L'unico modo per far ciò era chiamare la tua famiglia e farti mandare i soldi. La mia famiglia mandò i soldi e tornai a Tripoli.
Anche il mio secondo tentativo di partire dalla Libia fallì. La polizia vide un sacco di gente riunirsi per andare al mare. Fui arrestato di nuovo e mandato alla prigione di Al-Fellah nel novembre del 2006. Misero in prigione duecento persone quel giorno, io ero tra loro e mi finsi privo di sensi. Lo feci apposta. Mi misero da solo in un auto per essere interrogato. Fui interrogato tutta la notte, ma alla fine, credettero che stessi male.
A volte mi facevano domande. A volte mi prendevano a pugni. Questo era il prezzo da pagare per mostrare di essere svenuto. Mi riportarono all'abitazione dove ero stato arrestato. Tutte le altre persone arrestate quel giorno furono portate a Misurata. Era allora che Misurata cominciava ad essere un centro di detenzione. Feci il mio terzo tentativo di partenza dalla Libia nel giugno del 2007. Fummo raggruppati a Sabratha. Ancora una volta, fummo arrestati prima ancora di imbarcarci. Eravamo solo in 60. Ero fuori di me. Non mi importava di essere ammazzato o meno: provai a scappare e basta.
Alle porte della prigione, cominciammo tutti a correre. Circa 32 persone corsero in tutte le direzioni; 18 furono presi. Io ero tra questi. Quando mi catturarono, i comandanti sapevano che ero quello che aveva organizzato la fuga. Mi presi la punizione per tutti quelli che erano riusciti a scappare.
Mi picchiarono tre guardie con sbarre di legno e di metallo. Mi picchiarono per più di dieci minuti. Mi chiamavano ‘negro' mentre mi picchiavano. Quando caddi a terra, mi presero a calci. Mi colpirono in testa con una sbarra di metallo. Ho cicatrici e dolori alla testa. Ho ancora dolori alle spalle, le sbarre di metallo erano sottili, ma non si piegavano.
Mi picchiarono non appena mi presero. Quelli di noi che erano scappati, li legarono in un modo speciale. Per due giorni, ci tennero separati dagli altri. Ci buttavano acqua addosso. Non potevo camminare per i dolori all'inguine. Temevo davvero di avere un'emorragia interna alla testa. Non potevamo neanche sognarci di vedere un dottore o un infermiere.
Mi tennero a Sabratha per due settimane. A Sabratha tenevano circa cento persone. C'erano eritrei, africani occidentali, ed etiopi. Era un posto davvero sporco. Dovevamo urinare in bottiglie di plastica. Alcune delle persone che mi picchiarono all'inizio furono le mie guardie per le due settimane successive. Continuarono a trattarmi duramente. Continuarono a picchiarmi.
Quando c'era l'amministratore della prigione, il trattamento migliorava. Non ti picchiavano di fronte all'amministratore. Chiaramente, le guardie si drogavano. Quando erano sotto l'effetto di droghe, si sentivano superiori e ci trattavano come cani. È in quei momenti che ci prendono fisicamente a calci come cani.
Dopo due settimane a Sabratha, decisi di fuggire, scappai assieme ad altri riusciendo ad andarmene.
Al quarto tentativo riuscii a partire dalla Libia e a fare il viaggio. Partimmo da Garabulli, a Tripoli. C'erano 64 persone su un gommone Zodiac. Quando i Libici ci spinsero verso il mare, ci dissero che un liberiano avrebbe pilotato il gommone, ma furono dei nigeriani a portarlo in Italia. Viaggiammo per 16 ore. Il motore si era inceppato e la batteria del telefono si era esaurita, ma prima che ciò succedesse chiamammo la guardia costiera italiana. Il giorno dopo arrivò un elicottero. All'inizio del viaggio c'erano quattro imbarcazioni Zodiac. Due erano pieni di nigeriani. Arrivati a Lampedusa, venimmo a sapere che erano tutti dispersi.
Ci salvò la marina italiana. Ci trattarono con molto tatto. Ci portarono in Italia, a Lampedusa, il 4 ottobre 2007. Passammo una settimana lì. Non avemmo alcun problema. Da lì, io andai a Caltanissetta. Ci rimasi per un mese e 27 giorni. L'unico problema era che dovevamo pagare per i documenti. Dovemmo fare un pagamento ufficiale di 50 euro. Feci domanda d'asilo. Mi fu dato uno status umanitario. Non feci appello. Quando mi rilasciarono da Caltanissetta, mi ritrovai in mezzo alla strada. Andai a Roma.
Poi partii per la Svezia. Feci domanda d'asilo in Svezia. Ma gli svedesi mi dissero che ero stato in Italia. Avevano le mie impronte digitali. Mi misero su un volo di ritorno in Italia. La polizia italiana non fece niente. Mi presero le impronte digitali un'altra volta. E adesso vivo all'Anagnina in via Romanina [un grande edificio occupato dove vivono illegalmente molti africani]. Ho vissuto sempre lì.
Non ho possibilità di lavorare o studiare in Italia. Persino per il rinnovo dei miei documenti [di status umanitario] ci vogliono mesi. Ho dolori alle braccia e alle ossa. Secondo me, in questa vita ho pagato più di quanto dovessi.
Credo che qualcuno con un nome simile al mio abbia commesso qualche crimine. Di solito, quando la polizia controlla i miei documenti mi portano immediatamente alla stazione di polizia. Ogni volta che la polizia vede il mio nome mi arrestano come se fossi un pericoloso criminale. Passo un giorno in prigione, poi controllano le mie impronte e mi rilasciano.